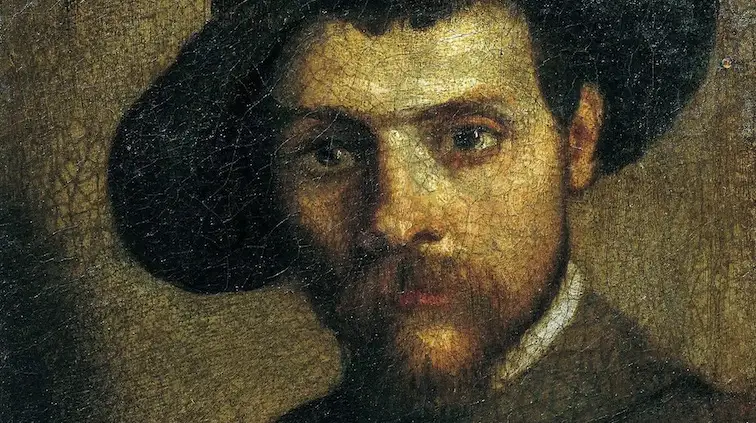Georgina Brooke rivoluziona la comunicazione museale con il suo libro sul digitale: strategie, storytelling e nuove sfide tra AI, SEO e pubblico globale
Nel panorama museale contemporaneo, dove la comunicazione online ha ormai un ruolo strategico, la pubblicazione del volume Digital Content in Museums: Delivering Discoverable, Usable and Strategic Content in Museums, Galleries and Heritage Institutions di Georgina Brooke, esperta di contenuti digitali e presidente del Museums Computer Group, segna una tappa significativa. L’autrice descrive il libro come “quello che avrei voluto leggere quando ho iniziato”, un manuale pratico per comprendere come rendere il digitale un motore di sviluppo e non un semplice strumento di supporto.
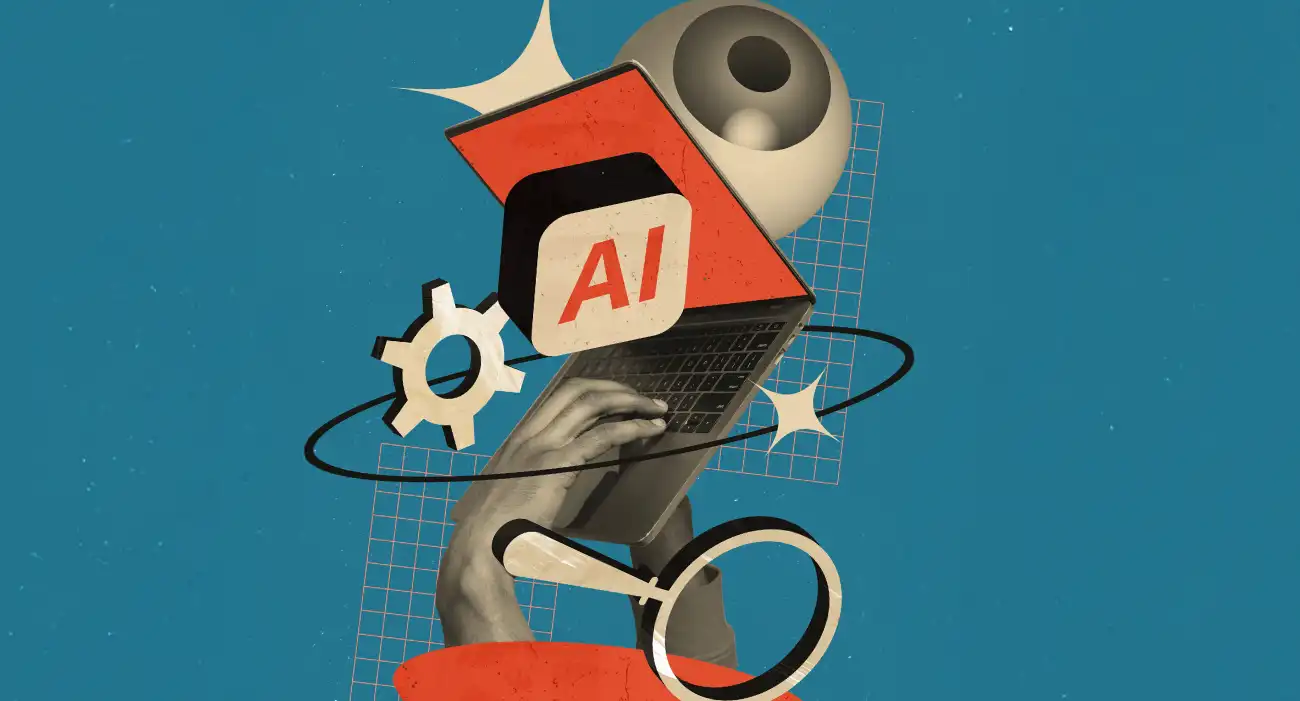
Quando pensavi che la SEO fosse morta ecco che diventa fondamentale in un settore come l’arte © immagine: intarget.net
Brooke individua nella mancanza di consapevolezza dirigenziale una delle barriere principali all’evoluzione digitale dei musei. Spesso le istituzioni trattano il digitale come un’estensione della promozione o come un complemento all’esperienza fisica in galleria, ignorando il suo potenziale strategico. Per l’autrice, invece, le piattaforme online devono essere considerate al pari delle sale espositive: spazi in cui si costruiscono relazioni e si ampliano pubblici, specialmente quelli finora trascurati o distanti.
Social media e strategie mirate
Uno dei fraintendimenti più comuni, osserva Brooke, riguarda la differenza tra contenuti organici e sponsorizzati sui social. Molti musei pubblicano post su eventi locali sperando che raggiungano il pubblico giusto senza alcuna forma di targeting, ma gli algoritmi penalizzano la scarsa interazione. I messaggi troppo specifici, destinati a un gruppo ristretto, dovrebbero essere sostenuti da campagne a pagamento. Al contrario, le storie più ampie e universali funzionano meglio in modo organico, poiché le piattaforme privilegiano ciò che trattiene gli utenti più a lungo.
Con l’avvento degli AI overviews, i siti culturali hanno registrato cali sensibili di traffico proveniente dai motori di ricerca. Secondo Brooke, chi continua a visitare i portali museali dopo aver superato la risposta automatica fornita dall’IA è un utente realmente motivato.
Questo calo di visite, seppur immaginiamo sarà momentaneo, apre comunque un’opportunità: trasformare quel visitatore in un frequentatore abituale, offrendo contenuti collegati, approfondimenti e magari un accesso a eventi o abbonamenti online. La chiave non è inseguire il volume di visite, ma curare l’esperienza di chi arriva.
“About me…”: la pagina che pochi leggono
Brooke cita ironicamente un detto del suo supervisore: “Se vuoi ritardare il lancio di un sito, apri la discussione su cosa scrivere nella pagina Chi siamo”.
Il problema, spiega, è che le istituzioni spesso riempiono queste sezioni di dichiarazioni interne e missioni istituzionali, mentre il pubblico cerca informazioni semplici: dove si trova il museo, cosa lo rende unico e se l’esperienza è adatta a loro. Il divario nasce dal concentrarsi sui pari e sui finanziatori invece che sui visitatori reali. I test con gli utenti, in questo senso, sono strumenti fondamentali per ritrovare la giusta prospettiva.
“Rivisitare i contenuti dalle fondamenta” non significa cancellare il passato, ma analizzarlo criticamente. Brooke suggerisce di combinare analisi quantitative, come audit manuali dei contenuti, e valutazioni qualitative, coinvolgendo i diversi dipartimenti. In questo modo si può stabilire cosa rinnovare, cosa mantenere e come pianificare le priorità in base agli obiettivi o alle scadenze del museo.
Dal catalogo digitale alla narrazione
Un esempio illuminante arriva dal Tank Museum, che ha compreso che il semplice archivio online non basta a intercettare nuovi pubblici. L’istituzione ha scelto YouTube come canale principale per raccontare storie e appassionare gli amanti dei carri armati di tutto il mondo. La piattaforma, con i suoi algoritmi di raccomandazione, ha moltiplicato la visibilità e ha trasformato l’interesse dei visitatori in dialogo e partecipazione attiva. È una lezione su come il digitale possa ampliare l’impatto culturale senza dipendere dalla visita fisica.
Equilibrio tra rigore e accessibilità. La storica tensione tra precisione accademica e linguaggio divulgativo può essere superata con una buona architettura dei contenuti. Il web, infatti, consente diversi livelli di approfondimento: un testo sintetico per il grande pubblico e link verso materiali più specialistici. Brooke sottolinea l’importanza di ridefinire i ruoli interni: gli esperti devono garantire la correttezza dei dati, ma lo stile e la leggibilità devono restare competenza del team digitale.

Georgina Brooke e la sua pubblicazione
Volendo creare una grande tabella completa sulle tematiche affrontate dalla Brooke, ecco il nostro spunto:
| # | Principio chiave | Spiegazione sintetica | Errore comune nel settore | Azione consigliata per musei e gallerie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital-first, non digital-support | Il digitale deve essere una piattaforma autonoma per raccontare storie, non solo un’estensione delle attività fisiche del museo. | Considerare il digitale solo come “supporto promozionale” agli eventi onsite. | Creare esperienze online complete, progettate per utenti che non visiteranno mai fisicamente il museo. |
| 2 | Leadership digitale consapevole | Il cambiamento digitale reale richiede il sostegno dei vertici direzionali. | Mancanza di competenze digitali tra i dirigenti, che delegano senza comprendere. | Formare la leadership sui fondamenti del digital content strategy e integrare obiettivi digitali nel piano istituzionale. |
| 3 | Contenuti organici vs. contenuti sponsorizzati | La comunicazione organica deve ispirare, quella sponsorizzata deve mirare a pubblici precisi. | Pubblicare su Facebook o Instagram eventi locali senza budget di targeting. | Usare campagne a pagamento per target specifici e riservare il feed organico a narrazioni universali e coinvolgenti. |
| 4 | SEO e AI-overviews | Le risposte generate dall’intelligenza artificiale riducono il traffico generico ma aumentano la qualità del pubblico che arriva al sito. | Puntare solo sul volume di visite, ignorando l’intento dell’utente. | Offrire contenuti approfonditi e interconnessi per fidelizzare chi arriva dopo una ricerca più mirata. |
| 5 | Rinnovare i contenuti da zero (“re-envisage”) | È necessario ripensare la struttura dei siti con audit quantitativi e qualitativi. | Aggiornare solo testi o immagini senza rivedere la strategia complessiva. | Creare audit dei contenuti, individuare sezioni sovraccariche o sottoutilizzate, pianificare in base agli obiettivi. |
| 6 | Raccontare storie digitali autentiche | Esempi come il Tank Museum mostrano il valore di piattaforme come YouTube nel costruire community internazionali. | Limitarsi alla digitalizzazione passiva delle collezioni. | Usare video, storytelling e interazione social per ampliare il pubblico oltre i confini nazionali. |
| 7 | Equilibrio tra accuratezza e accessibilità | È possibile unire rigore scientifico e linguaggio semplice con una strategia di “progressive disclosure”. | I curatori insistono su testi troppo tecnici per il pubblico generale. | Separare il ruolo dei curatori (verifica) da quello dei digital designer (scrittura e user experience). |
| 8 | Competenze digitali professionali e riconosciute | Il content design deve essere riconosciuto come disciplina autonoma nel settore museale. | Sottovalutare le competenze digitali, affidandole a ruoli junior o stagisti. | Istituire posizioni dedicate alla content strategy, SEO e UX design con percorsi formativi certificati. |
| 9 | Uso responsabile dell’intelligenza artificiale | L’AI può essere utile per analizzare grandi dati o automatizzare compiti, ma non deve sostituire la creatività. | Usare tool AI senza policy o senza comprendere i rischi sui dati sensibili. | Redigere una policy sull’uso dell’AI, sperimentare progetti pilota, mantenere la supervisione umana. |
| 10 | Misurare e migliorare le esperienze digitali | Ogni contenuto deve essere tracciato e ottimizzato in base ai percorsi reali dell’utente. | Creare contenuti senza monitorare come gli utenti interagiscono. | Implementare strumenti di analytics e A/B testing per adattare la strategia ai comportamenti del pubblico. |
Intelligenza artificiale e futuro del settore
L’autrice rileva come l’interesse verso l’IA sia cresciuto, ma la fiducia rimanga limitata. Pochi musei hanno una politica chiara sull’uso di questi strumenti, sebbene alcuni casi virtuosi – come la National Gallery of Art di Washington – li stiano impiegando per analizzare enormi quantità di feedback dei visitatori. L’intelligenza artificiale può quindi diventare un alleato, ma servono regole chiare e risorse dedicate per utilizzarla in modo etico e sostenibile.
Il digitale nei musei deve essere considerato come un ecosistema narrativo autonomo, non solo come un canale di comunicazione. Le istituzioni culturali efficaci saranno quelle in grado di offrire esperienze digitali coinvolgenti, misurabili e accessibili a un pubblico ampio.
Brooke conclude auspicando che il lavoro sui contenuti digitali venga riconosciuto come una disciplina autonoma e certificata. La scoperta, l’usabilità e la strategia dovrebbero diventare i pilastri di una nuova professionalità museale, capace di coniugare conoscenza, empatia e innovazione.
L’analisi di Georgina Brooke si inserisce in un contesto in cui i musei europei e italiani stanno ridefinendo la propria identità digitale.
Torino, Firenze, Roma e Milano stanno sperimentando approcci simili per rendere i patrimoni culturali più accessibili anche online, sfruttando intelligenza artificiale, SEO avanzata e storytelling interattivo. La prospettiva offerta dal libro suggerisce una strada chiara: integrare tecnologie e contenuti per creare esperienze digitali autentiche, capaci di dialogare con visitatori globali e locali allo stesso tempo.
© credits: museumsandheritage.com